1) Introduzione terminologica
Un conflitto avviene quando si ha una divergenza d’interessi o di opinioni fra due o più parti. La Repubblica Democratica del Congo, nella sua evoluzione storica, è stata dilaniata da molti conflitti, di cui subisce tutt’ora gli effetti.
Caratteristica che contribuisce ad aumentare la complessità dei conflitti in RDC è la presenza di molteplici etnie sul suo territorio, che ammontano all’incirca a 250.
Un’etnia si può definire come un gruppo di persone omogeneo, ossia che condivide al suo interno lingua, cultura e tradizioni, rivendicando un’identità comune. Spesso accade che un gruppo etnico si riunisca in una tribù, la quale ha una coesione di carattere territoriale oltre che linguistica e sociale.
Spiegare la storia delle etnie che compongono la Repubblica Democratica del Congo non è affatto facile, e non sarà lo scopo di questo articolo, che invece intende focalizzarsi sulla recente questione del gruppo ribelle M23 e il suo ruolo nella regione orientale del Paese. Il gruppo M23, infatti, si è costituito a partire da un conflitto d’interessi tra diversi gruppi etnici. Rappresenta un esempio concreto di come la complessità etnica possa sfociare in scontri armati. Nei paragrafi successivi si spiegheranno le origini del gruppo M23 e le sue caratteristiche principali. Inoltre, si mostrerà come tale gruppo abbia contribuito a provocare un clima di instabilità nella provincia del Nord Kivu, situata nella parte orientale della RDC. Nei primi paragrafi, si tenterà innanzitutto di fornire alcune coordinate sulle origini etniche della RDC. In questo modo, si fisserà un contesto e una misura della vasta eterogeneità di popolazioni presenti sul suo territorio.
Per concludere, lo scritto mira a spiegare come Magic Amor operi per fornire un appoggio e una speranza alle tante vittime civili dei conflitti etnici che hanno tormentato il Paese.
2) Origini etniche in Repubblica Democratica del Congo
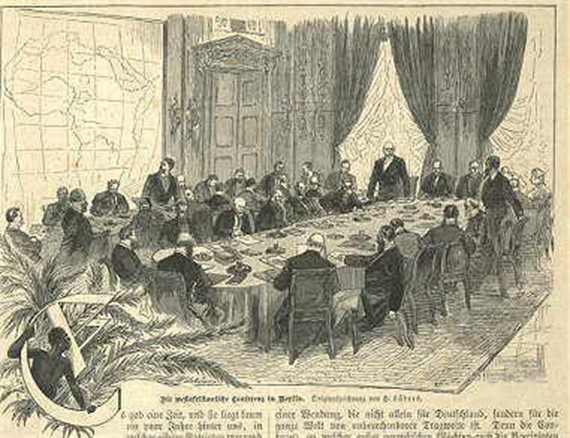
Partendo dalle
origini delle differenti etnie in Repubblica Democratica del Congo, è possibile
risalire alle prime popolazioni stanziatesi sul suo territorio. Precedentemente
al 2000 a.C., in RDC erano già presenti i Pigmei e i Nilotici, principali
gruppi autoctoni di cui si ha testimonianza.
Tuttavia, sarà solo a seguito della grande ondata migratoria della popolazione Bantu,
proveniente dal Nord Africa, precisamente dal territorio degli attuali Camerun
e Nigeria, che la RDC si costituì in molteplici gruppi etnici. Questi ultimi
formeranno dei clan che poi si raggrupperanno in quattro Regni: il Kongo, a
sud-ovest della Repubblica Democratica del Congo; il Regno Kuba, nel centro
della RDC; l’Impero Luba, che dalla parte centrale si estende fino al
nord-ovest del Paese e l’Impero Lunda, che occupava gran parte del centro fino
all’area a sud-est della RDC.
I Regni costituivano veri e propri Paesi, con una loro indipendenza, e una
propria identità culturale; riusciranno a superare le controversie che si
creeranno fra loro ricorrendo ad accordi e alleanze, vivendo un periodo di
stabilità.
A cambiare questa situazione di equilibrio sarà la Conferenza di Berlino del
1884-1885, conosciuta anche come Conferenza sul Congo. Oltre a regolare il
commercio europeo in Africa centro-occidentale nelle aree dei fiumi Congo e
Niger, infatti, la Conferenza sancì la nascita dello Stato libero del Congo
sotto l’influenza di Leopoldo II del Belgio. Il sovrano belga riunì così tutti
i territori congolesi, costituendo uno Stato indipendente, su cui esercitava un
controllo personale quasi assoluto. Conseguentemente, ignorava del tutto le
differenze esistenti tra i quattro Regni, sfruttando la popolazione locale che
venne impiegata nella raccolta di caucciù. A partire dal 1908, il Congo belga
divenne una colonia vera e propria; quindi, iniziò un forte afflusso di coloni
dall’Europa e proseguì lo sfruttamento economico delle immense risorse del
territorio. Gli anni del colonialismo termineranno ufficialmente il 30 giugno
1960, con la proclamazione dell’indipendenza del Congo.
3) Ripartizione geografica delle grandi tribù in RDC

Avere un quadro generale dei principali gruppi etnici presenti in Repubblica Democratica del Congo permette di orientarsi nella complessità e diversità delle tribù che lo caratterizzano.
Innanzitutto, vi sono i Bakongo, abitanti del regno del Kongo, corrispondente al Kongo-Central di oggi. In secondo luogo, i Kuba, di cui fanno parte le etnie Pende, Mbala e Kuba.
Considerando poi la ripartizione geografica delle tribù più importanti in RDC, si individuano: le grandi etnie dei Mongo, Bangala, Mbuza che occupano il nord-ovest del Paese, nella provincia dell’Equatore, dove è presente la foresta equatoriale; a nord-est del Paese, nella provincia orientale, invece, Mbangi, Ngombe e Doku, popolazioni di pescatori provenienti dal Sudan, che al loro arrivo hanno combattuto con i Mbenza per il controllo dei loro territori; al centro del Paese e nella regione del Grand Kasai, vi sono Luba e Tetela; a sud-est Kunda e Keti; a est Nande, Barega, Kumu, e Lega.
Ciascun popolo occupa una parte specifica del territorio, in accordo con il principio della propriété du sol. Inizialmente, tale principio si traduceva nella possibilità per ogni individuo di rendersi liberamente proprietario di un certo territorio. Successivamente, con la legge “Bakajika” del 7 giugno 1966, finalizzata a regolare il regime giuridico della proprietà fondiaria, il suolo e sottosuolo del territorio della RDC appartenevano allo Stato congolese. Grazie alla legge del 20 luglio 1973, il quadro giuridico relativo al regime della proprietà verrà completato e rafforzato. Di conseguenza, il suolo e sottosuolo congolese, da quel momento, costituiscono una proprietà esclusiva, inalienabile e imprescrittibile dello Stato. Pertanto, solo lo Stato detiene il potere di concedere il diritto di fruizione del suolo a individui o comunità locali.
La descrizione effettuata circa le origini etniche delle popolazioni che abitano il territorio congolese e la complessa ripartizione geografica delle tribù presenti oggi sono un indicatore della diversità culturale del Paese. Tale diversità, se è fonte di ricchezza da un punto di vista identitario, può concorrere a creare situazioni di contrasto fra differenti gruppi etnici. L’affermarsi del Movimento del 23 Marzo a partire dal 2012 nella provincia del Nord Kivu è una dimostrazione di come il fattore etnico eserciti un peso rilevante nel manifestarsi di lotte armate.
4) Origini della ribellione e rivendicazioni del gruppo M23
Il territorio orientale della Repubblica Democratica del Congo è ormai da decenni travagliato da scontri e violenze, portatrici di instabilità sociale e di una profonda crisi umanitaria, divenute insostenibili per la popolazione locale. Tra i protagonisti di questa vicenda figura il gruppo degli M23.
Il Movimento del 23 marzo, gruppo militare ribelle conosciuto anche come M23 si costituì nel 2012 nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Diretto dal comandante Sultani Makenga, questo movimento si compose a partire dal CNDP (Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo), formazione paramilitare di etnia Tutsi di base nelle province orientali della RDC, creata da Laurent Nkunda. Il CNDP negli anni ha assunto un ruolo fondamentale nel conflitto del Kivu, combattuto dalle milizie della regione contro le forze governative della Repubblica Democratica del Congo.
Per comprendere le origini e le cause della formazione del gruppo M23 è necessario fare un passo indietro fino al 1994, durante il genocidio dell’etnia Tutsi verificatosi in Ruanda, Paese confinante a oriente con la RDC. In quegli anni al governo con il presidente ruandese Juvénal Habyarimana vi erano forze esponenti dell’etnia Hutu, la quale si scontrerà con la contrapposta etnia Tutsi nella guerra civile che si protrasse dal 1990 al 1993. L’odio interetnico molto diffuso tra Hutu e Tutsi costituì la causa scatenante del conflitto che culminò con il genocidio dell’etnia Tutsi e della componente moderata degli Hutu.
A causa di questo episodio, tra i più violenti e sanguinosi nella storia del XX secolo, le popolazioni Tutsi insieme agli Hutu più moderati fuggirono per rifugiarsi nella vicina RDC. Il leader Joseph-Désiré Mobutu, al tempo dittatore della Repubblica Democratica del Congo, da lui rinominato Zaire, scelse di accogliere i profughi ruandesi nella zona orientale del Paese, aprendo le frontiere.
Mentre il governo ruandese inviava militari nel territorio della RDC per tracciare i Tutsi, questi ultimi si univano agli Hutu moderati per formare i Banyamulenge.
Riguardo la storia del gruppo dei Banyamulenge bisogna considerare che non vi è pieno accordo sulla loro identità. Secondo altre fonti, infatti, i Banyamulenge costituiscono una minoranza etnica all’interno della RDC, nella provincia del Sud Kivu. Stanziatesi in quest’area tra il XVI e il XVIII secolo, emigrando dai luoghi corrispondenti agli attuali Burundi, Ruanda, Tanzania e Uganda, una parte dei Banyamulenge avrebbe scelto, tra gli anni Sessanta e settanta del secolo scorso, di migrare nella regione meridionale del Katanga nella RDC.
Tuttavia, nel 1998 quasi 20.000 Banyamulenge sono stati costretti a fuggire dal Katanga, dopo aver subito un attacco, perché considerati “stranieri” in quel territorio. Per questo motivo ai Banyamulenge, negli anni 80 del XX secolo, è stata negata la cittadinanza e un decennio più tardi lo Stato congolese ha richiesto la loro espulsione dal Paese, a seguito di una risoluzione parlamentare che aveva lo scopo di far rientrare nelle loro terre d’origine tutti i discendenti ruandesi e burundesi. L’ideologia secondo la quale i Banyamulenge siano degli invasori e non abbiano diritto a risiedere sul suolo congolese è stata tramandata tra le generazioni, alimentando un sentimento di odio e provocando violenze e attacchi da parte di gruppi e milizie armate contro questa popolazione. Tali atti di forza sono stati appoggiati dalla mancanza di azione dell’armata regolare congolese.
Il gruppo dei Banyamulenge si ritrovò dunque a combattere non solo le forze ruandesi, ma anche le popolazioni autoctone congolesi.
Inoltre, un fattore molto importante da considerare era che la zona in cui i Banyamulenge si erano stanziati è ricca di coltan, minerale molto prezioso e utilizzato per la produzione di apparecchi elettronici. Pertanto, oltre a rivendicazioni politiche e contrasti dovuti ad appartenenze etniche diverse, risulta lampante la presenza di interessi economici in gioco, dove a farne le spese, purtroppo, sono gli individui più fragili.
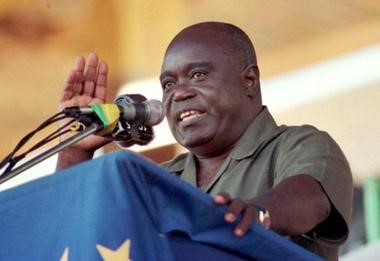
Un punto di svolta,
che provocò poi la nascita del gruppo M23, si ebbe con la figura del leader
ribelle congolese Laurent Kabila. Il suo obiettivo era di rovesciare il governo
Mobutu, diventando egli stesso Presidente. Per poter riuscire nel suo intento, iniziò
dei negoziati per intessere alleanze: in particolare, ottenne l’appoggio dei
Banyamulenge, offrendogli, in cambio del loro aiuto, i territori a est della
RDC. Ciò nonostante, autoproclamatosi presidente della Repubblica Democratica
del Congo nel 1997, Kabila non terrà fede alla parola data, provocando il
nascere di un disaccordo con il CNDP, che sfocerà nel conflitto del Kivu, tra
il 2004 e il 2009.
Con la firma del Trattato di pace a Goma, il 23 marzo 2009, il governo
congolese e il CNDP tentarono di avviare un processo di riconciliazione che
prevedeva l’accettazione da parte del CNDP alla propria trasformazione in un
partito politico, in cambio della scarcerazione dei suoi membri. Contrariamente
a quanto sperato, le operazioni condotte fino alla fine del 2009 non hanno condotto
alla pace e sicurezza nelle regioni orientali del Congo, esasperando la già
grave crisi umanitaria presente.
Proprio dalla volontà di sottolineare il carattere fallimentare degli accordi
del 23 marzo 2009 deriva il nome del Movimento del 23 marzo, che iniziò le sue
attività ad aprile 2012, quando alcune centinaia di soldati disertarono
l’esercito del Congo – lamentandosi per le condizioni di vita in cui erano
costretti – e si unirono agli insorti di etnia Tutsi guidati da Ntaganda. Nello
stesso periodo, il governo centrale del Congo, guidato da Joseph Kabila, minacciò
di trasferire via dal Nord e dal Sud Kivu gli ex soldati del CNDP. L’annuncio provocò
un ulteriore aumento delle diserzioni e la decisione del M23 di marciare verso
Goma.
Ma quali sono le rivendicazioni del gruppo M23 oggi? Da un lato, il Movimento intende
ottenere il controllo del territorio orientale della RDC: in questo modo
avrebbe uno spazio in cui il suo popolo, il gruppo Banyamulenge, potrebbe
stanziarsi. Dall’altro, invece, mira a raggiungere il riconoscimento dei
Banyamulenge come etnia congolese. Tramite l’approvazione del gruppo come etnia
all’interno del contesto della RDC, infatti, l’M23 acquisirebbe il diritto di
entrare a far parte dell’armata regolare, conquistando la piena integrazione.
5) Ruolo della MONUSCO

Un attore da prendere in considerazione, quando si
analizza la situazione della RDC in relazione al gruppo ribelle M23, è la
MONUSCO, acronimo della missione dell’ONU per la stabilizzazione nella
Repubblica Democratica del Congo. Istituita dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite nel maggio 2010, prese il posto della missione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo
(MONUC), operativa dal febbraio 2000.
La creazione della MONUSCO, di conseguenza, rispondeva alla necessità di
protezione della popolazione civile coinvolta negli scontri, mantenendo un
carattere di imparzialità, senza favoreggiare nessuno schieramento. Nonostante le
operazioni di peacekeeping risultino spesso uno strumento efficace
nell’aiutare i Paesi a percorrere il difficile percorso transitorio dal
conflitto alla pace, ci sono state delle criticità nel rapporto tra la MONUSCO
e la popolazione locale in RDC. In particolare, sono da segnalare delle
difficoltà che la MONUSCO ha dovuto affrontare nell’area orientale del Paese: l’incapacità
delle forze dell’ONU di agire
efficacemente a causa di metodi di attuazione dei programmi inadatti al
contesto e
l’inabilità a muoversi sul terreno della
RDC, data la sua geografia. Questi sono alcuni dei motivi per cui parte della
popolazione congolese e lo stesso governo, a seguito di una serie di
manifestazioni nell’estate 2022, ha chiesto la partenza anticipata della
MONUSCO prevista entro il 2024.
D’altro canto, malgrado l’incapacità odierna di contribuire alla
stabilizzazione del Paese e di contrastare l’M23, è importante ricordare il ruolo
che la MONUSCO ha svolto nel mitigare le azioni dei gruppi armati nella RDC
durante gli ultimi 20 anni. Quando la MONUC ha iniziato il suo intervento nel 2000,
infatti, il Paese era afflitto da molteplici sfide, tra cui la presenza di
eserciti stranieri e gruppi armati che minacciavano la stabilità e l’integrità
territoriale del Paese. Le decisive operazioni congiunte MONUC – FARDC (Forze Armate della Repubblica
Democratica del Congo) contro questi gruppi nel Sud e Nord Kivu hanno
contribuito in modo significativo a deteriorare le loro operazioni di terrore
sulla popolazione civile e l’instabilità delle istituzioni.
Tuttavia, permangono contrasti fra l’attuale MONUSCO e il governo congolese: all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite dello scorso settembre il presidente Félix Tshisekedi ha
chiesto che il ritiro graduale della Missione avvenga a partire dal dicembre
2023. Oltre al lavoro poco efficace svolto dalla MONUSCO nei 23 anni in cui è stata presente sul
territorio congolese per riportare stabilità, a spingere il Presidente a
richiedere il ritiro anticipato ci sono probabilmente anche le elezioni
previste per il 20 dicembre, per ottenere il favore della fetta di popolazione che
negli ultimi anni ha manifestato contro le truppe ONU.
6) L’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio

Un drammatico episodio che testimonia come la tensione e l’instabilità siano ancora forti nella zona del Nord Kivu in RDC è l’assassinio dell’ambasciatore Luca Attanasio da parte di una banda criminale. L’attacco, avvenuto il 22 febbraio 2021, coinvolse un convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, all’altezza di Kibumba, a 25 km da Goma, capitale della provincia del Nord Kivu. Il convoglio era diretto a Rutshuru, all’interno del Parco Nazionale Virunga, per visitare un progetto di alimentazione scolastica, ma non riuscì a raggiungere la destinazione programmata: l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e un autista congolese del PAM , Mustapha Milambo, vennero uccisi.
Le circostanze in cui si è verificato il triplice omicidio non sono state ancora del tutto chiarite, nonostante il 6 aprile scorso siano stati condannati all’ergastolo sei uomini accusati dalle autorità congolesi. Le persone in questione sono state individuate come parte di un gruppo criminale che non voleva uccidere ma rapire l’ambasciatore per ottenere un riscatto.
Rimangono ancora dubbi sulla responsabilità degli addetti dell’ONU a Goma e dei funzionari del PAM, dato che quel giorno era stata dichiarata un’allerta di sicurezza e molti militari erano stati richiamati a Goma lasciando sguarnita la strada. Trovare la verità sul caso dell’ambasciatore italiano potrebbe rivelarsi importante anche per i congolesi, che in quelle zone sono vittime di violenze ogni giorno, e potrebbe inoltre agevolare la ricerca finalizzata a far luce sulla guerra del Kivu.
7) Ripercussioni del conflitto sulla popolazione locale e ruolo di Magic Amor

In questa situazione travagliata che si trascina da ormai
molti anni, coinvolgendo le regioni orientali della RDC, le persone che
maggiormente subiscono le conseguenze degli scontri, subendo soprusi, violenze,
vivendo in condizioni precarie e di povertà, sono donne e bambini.
Tante donne per poter sopravvivere sono costrette a prostituirsi, mentre molti
bambini rimangono orfani: a volte diventano bambini soldato o vengono presi a
lavorare nelle miniere.
Secondo il rapporto condotto da Amnesty International, tra il 2022 e il 2023, i
gruppi armati in RDC si sono resi responsabili della morte di più di 1800
civili, mentre 600.000 sono state le persone sfollate internamente.
Risale a soli pochi giorni fa, il 24 ottobre, un massacro di civili attribuito
ai ribelli delle Forze democratiche alleate e intensi combattimenti tra forze
governative e ribelli del gruppo M23 nel Nord Kivu. In un rapporto pubblicato
il 23 ottobre, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha
affermato che dal primo ottobre quasi 200.000 persone sono state costrette a
lasciare le loro case nei territori di Rutshuru e Masisi.
Magic Amor esiste per dare un futuro e una prospettiva diversa alle numerose
vittime di maltrattamenti, crimini e violazioni dei diritti umani che si
verificano in RDC. La sua missione nasce proprio dalla volontà di rispondere ai
bisogni della popolazione congolese, che progressivamente, negli ultimi decenni,
ha subito un deterioramento sociale, culturale ed economico.
Come testimoniato da un’associazione amica di Magic Amor che opera nel campo
dei rifugiati Kibati, ai piedi del vulcano Nyiarangongo, a circa 20 km dalla
città di Goma, la situazione dei civili in questa zona è estremamente precaria,
con il dilagare delle malattie e i continui atti di forza che le persone sono
costrette a subire, vivendo nella paura e nella miseria.
Grazie all’operato di Magic Amor, si può dare un’alternativa e una nuova
speranza alla popolazione congolese. Dal 2002, l’associazione è riuscita a
realizzate decine di strutture scolastiche, formando più di 15.000 bambini. Attualmente
nel quartiere di Kimbuta, zona situata nella periferia di Kinshasa, è attivo il
centro polivalente, composto dalla scuola primaria e secondaria Rocco Campagna,
dall’ambulatorio Antonino Nicolosi e dall’orfanotrofio Maison des enfants San
Marcello. In questi luoghi Magic Amor ha accolto e accoglie ancora oggi tanti
bambini e ragazzi vittime di sfruttamento, offrendogli la possibilità di vivere
in sicurezza, costruendo il proprio futuro in un ambiente sereno e amorevole.
Inoltre, tanti bambini che sono cresciuti all’interno delle strutture di Magic Amor
hanno avuto l’opportunità di continuare gli studi e di formarsi per svolgere
una professione, diventando maestri, medici, direttori nel contesto di Magic
Amor.
Per rendere questo aiuto possibile e continuativo c’è bisogno anche del tuo
aiuto. Scopri
come sostenere i nostri
progetti e diventare parte della nostra realtà solidale.
Camilla Ballanti

